Un giro del mondo in 120 minuti.
Dalla terra, al cielo, allo spazio. La giornalista e antropologa
Paola Antolini ci guida in una spedizione attraverso scoperte
sorprendenti, intelligenze umanoidi, verso paradisi naturali
inesplorati e fino a oltre l’atmosfera.
di Ornella Realmonte, 5LX
 In
occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella
scienza, l’11 febbraio 2022, Palazzo Farnese accoglie tre
straordinarie scienziate europee: Claudie Haigneré, prima astronauta
donna europea a volare sulla Stazione Spaziale Internazionale,
Chiara Montanari, ricercatrice presso la base Concordia in
Antartide, e Alessandra Sciutti, biorobotica dell’Istituto Italiano
di Tecnologia.
In
occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella
scienza, l’11 febbraio 2022, Palazzo Farnese accoglie tre
straordinarie scienziate europee: Claudie Haigneré, prima astronauta
donna europea a volare sulla Stazione Spaziale Internazionale,
Chiara Montanari, ricercatrice presso la base Concordia in
Antartide, e Alessandra Sciutti, biorobotica dell’Istituto Italiano
di Tecnologia.
La conferenza, organizzata dall’Ambasciata di Francia in Italia e
dall’Institut français, offre la possibilità a giovani studenti di
interagire con queste grandi donne di scienza, di intervistarle e di
trarre ispirazione dalle loro storie ricche di esperienze, impegno e
traguardi. Il tutto grazie anche alla collaborazione della
mediatrice, che ha permesso la traduzione simultanea della tavola
rotonda in italiano e in francese, dal vivo e in diretta streaming.
L’incontro si apre con un intervento del ministro consigliere
dell’ambasciata, Cristophe Lemoine, con un discorso sulla disparità
di genere nelle discipline STEM, le cosiddette “discipline del
futuro”, oggi prevalentemente frequentate da una maggioranza
maschile. Per tale ragione, esprime la sua gratitu-dine e la sua
felicità per l’occasione di incontrare queste tre grandi donne che
hanno fatto la differenza, e concede la parola a Claudie
Haigneré.
 Dopo
un breve video di presentazione, la scienziata francese racconta
come, da medico reumatologo, è riuscita ad essere selezionata per
seguire il suo sogno adolescenziale, diventare un’astronauta.
Insie-me ad un team del CNES (Centro Nazionale di Studi Spaziali)
interamente maschile, ha compiuto la mis-sione franco-russa
Cassiopea, nel 1996, per poi essere la prima donna europea a volare
a bordo della Stazione Spaziale internazionale (ISS) nel 2001. «Quando
si è in preda alla curiosità, si è alla ricerca, si vuole scoprire,
lì diventa facile parlare di bellezza» ci dice la scienziata,
riprendendo una massima di Marie Curie. E aggiunge: «Guardando
dall’oblò vediamo la Terra così fragile, vulnerabile, ma bellissima.
A volte ci sono delle bellezze un po’ oscure, utopiche, quindi
bisogna essere responsabili e stare attenti, ma soprattutto spingere
le porte e andare oltre, essere curiosi».
Dopo
un breve video di presentazione, la scienziata francese racconta
come, da medico reumatologo, è riuscita ad essere selezionata per
seguire il suo sogno adolescenziale, diventare un’astronauta.
Insie-me ad un team del CNES (Centro Nazionale di Studi Spaziali)
interamente maschile, ha compiuto la mis-sione franco-russa
Cassiopea, nel 1996, per poi essere la prima donna europea a volare
a bordo della Stazione Spaziale internazionale (ISS) nel 2001. «Quando
si è in preda alla curiosità, si è alla ricerca, si vuole scoprire,
lì diventa facile parlare di bellezza» ci dice la scienziata,
riprendendo una massima di Marie Curie. E aggiunge: «Guardando
dall’oblò vediamo la Terra così fragile, vulnerabile, ma bellissima.
A volte ci sono delle bellezze un po’ oscure, utopiche, quindi
bisogna essere responsabili e stare attenti, ma soprattutto spingere
le porte e andare oltre, essere curiosi».
Per questo, la Haigneré ribadisce l’importanza dell’amore per la
diversità, affinché la Terra non sia così “vulnerabile” come si vede
da lassù, a causa dell’attività umana.
Per quanto riguarda i propositi futuri, il team spaziale punta
all’installazione di infrastrutture sulla Luna per imparare a
viverci. Un obiettivo sicuramente ambizioso, ma per Claudie nulla è
irraggiungibile: Per aspera ad astra, attraverso le
difficoltà, fino alle stelle.
A questo punto, il testimone passa a Chiara Montanari,
in collegamento da remoto, che rivela come si sia ritrovata nel
mondo dell’ingegneria per caso, durante un percorso di studi «inaspettato,
ma straordinario». La scienziata lavora nella base
italo-francese Concordia, in Antartide, dove si ricerca per capire
quali direzioni sta prendendo il cambiamento climatico. La base è
situata in una distesa totalmente vuota, bianca, ghiaccia,
accessibile dopo più di 30 ore di viaggio, ma mozzafiato. «È una
sensazione pazzesca» afferma la Montanari, «Una sensazione
di deprivazione sensoriale ma dolce, un’assenza di stimoli totale,
perché non ci sono odori, non ci sono colori, e si ha questa
impressione di essere abbracciati dalla Volta Celeste, quasi a
contatto con l’Universo».
Lì la natura ha ritmi estremi, le condizioni climatiche cambiano
repentinamente, è come un salto nell’ignoto, ma in questo senso
l'Antartide è una sorta di metafora del mondo contemporaneo: la
sfida dell’imprevisto, che si traduce in una fonte di apprendimento,
una chiamata alla vitalità. «Concordia è un esempio di
collaborazione, perché non possiamo pensare di lavorare o di vivere
in un mondo come quello di oggi senza farlo insieme agli altri».
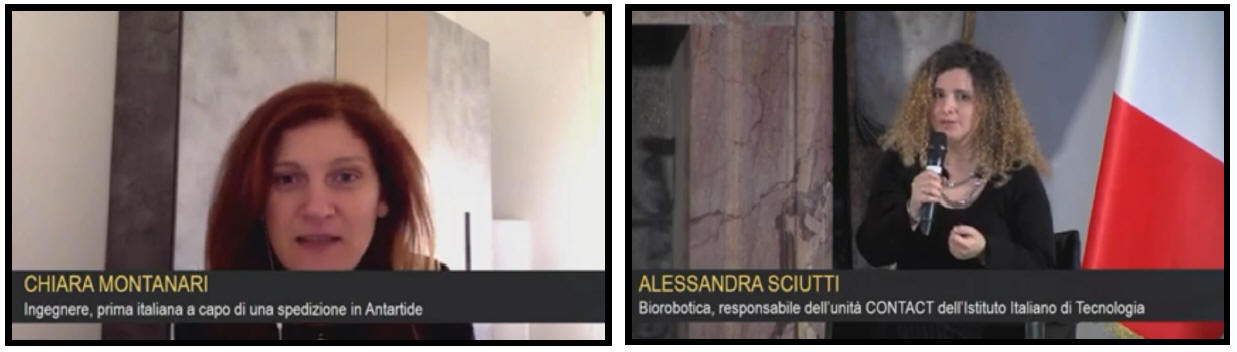
L’ultima ad intervenire è Alessandra
Sciutti, che nella sua vita ha subito una metamorfosi
dal-la bioingegneria alla robotica. Inizialmente era affascinata
dall’analisi della mente umana e dal suo funzionamento, finché non
si è resa conto che vi è un tipo di intelligenza che può superare i
limiti dell’uomo, la robotica umanoide. Il progetto ROBOCAB ha
ap-portato, a tal proposito, la creazione di «un essere
intelligente per capire gli esseri intelligenti»: iCub.
Attraverso questo bambino-robot, si studiano meccanismi sensoriali,
motori e cognitivi che vi stanno alla base dell’interazione umana. «Cercare
di trasferire le nostre abilità e capacità su una macchina ci
costringe per forza a guardarci da una nuova prospettiva, porci
domande nuove. È un po’ come uno strano tentativo di farsi un
autoritratto.» La caratteristica della robotica che più
apprezza la Sciutti è appunto la possibilità di conoscere meglio
l’uomo attraverso un’intelligenza artificiale, il confronto, il
dibattito, lo scambio di idee. Infatti, è entusiasta di aver avuto
la possibilità di viaggiare molto e conoscere diverse culture e
saggezze provenienti da tutto il mondo.
In conclusione, il convegno si presenta come un grande stimolo per
gli studenti. Le scienziate li invitano a seguire le proprie
passioni, a non fermarsi davanti agli ostacoli e ad affrontare le
proprie paure. Perché nella scienza “quando qualcuno vince,
vincono tutti”.






